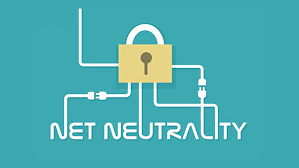«Quando le attuali regole saranno abolite, la neutralità della rete somiglierà a uno stregatto: saremo in un mondo in cui la regolazione si dissolve nell’oscurità e tutto ciò che resta sarà il sorriso sdentato di un fornitore di banda larga e le sue confortanti parole: “abbiamo tutti gli incentivi per fare la cosa giusta”. Ma ciò che presto avranno, saranno gli incentivi a fare la cosa giusta per loro.»
Con queste parole Mignon Clyburn, commissario della Federal Communications Commission in quota democratici, argomenta la sua dissenting opinion alla decisione assunta il 14 dicembre dalla FCC, che pone un altro importante tassello sulla vicenda della neutralità della rete statunitense.
Fin da prima della sua elezione il Presidente Donald Trump ha lasciato intendere quale sarebbe stata la sua politica in tema di comunicazioni elettroniche. I nomi scelti per il transition’s team incaricato di supervisionare il passaggio della FCC dal controllo democratico a quello repubblicano erano idonei a fugare ogni dubbio: Jeffrey Eisenach, già consulente Verizon, Roslyn Layton e Mark Jamison (noto per non ritenere utile un ente come la FCC).
I tre hanno inoltre in comune partecipazione all’American Enterprise Institute (considerato un think tank del libero mercato). Ne consegue che la nomina di Ajit Pai, da sempre critico riguardo alle regole sulla neutralità della rete, a Presidente della FCC non è stata una sorpresa.
Per la verità, il Presidente degli Stati Uniti non si era mai espresso chiaramente sulla net neutrality. Tra i pochi interventi sul tema è però noto un tweet del 2014 in cui, criticando la politica appoggiata da Obama, afferma che “Net neutrality is the Fairness Doctrine”.
Che cos’è la fairness doctrine? Se in generale la policy rievoca l’idea di pluralismo informativo, nel dettaglio essa si presenta come una realtà più complessa, imponendo alle emittenti televisive e radiofoniche di dedicare parte della programmazione a questioni di pubblico interesse e di dare spazio a opinioni contrastanti.
Entrata in vigore nel 1949, e ritenuta legittima dalla Corte Suprema in Red Lion Broadcasting Co. V. FCC, 395 U.S. 367 (1969) la dottrina fu per buona parte abbandonata nel 1987 a seguito di una decisione della stessa FCC, confortata dalla pronuncia Syracuse Peace Council v. FCC, 867 F.2d 654 (D.C. Cir. 1989), in cui la Corte la Corte d’appello federale per il distretto della Columbia confermò che la doctrine era una commission policy della FCC non imposta dalla legge (nel qual caso per l’abbandono sarebbe stata necessaria una pronuncia del Congresso). Successi tentativi di reintrodurre per via legislativa la dottrina sono stati fermati dai veti di D. Regan (1987) e George H.W. Bush (1991).
L’idea di Trump e dei repubblicani è che se la fairness doctrine ha permesso all’esecutivo di affermare cosa fosse lecito e doveroso affermare per il rispetto della medesima dottrina (pena, tra l’altro, la revoca delle licenze), altrettanto potrebbe fare la neutralità della rete: il governo (di cui l’FCC rappresenterebbe la longa manus) con essa si espande anche sulla rete, stabilendo (arbitrariamente?) quali condotte devono tenersi affinché siano considerate neutrali.
L’analogia tra fairness doctrine e net neutrality solleva tuttavia talune perplessità. Solo la prima imponeva alle emittenti una serie di attività positive, mentre la net neutrality è formulata in termini negativi, così da impedire la discriminazione tra i pacchetti di dati. Se da un lato si imponeva all’emittente di ingerirsi nella programmazione, dall’altra si chiedeva agli ISP (e per estensione all’esecutivo) di non mettere interferire su cosa – di legale – passasse per la rete. Se pertanto con la fairness doctrine l’emittente televisiva avrebbe finito col fare da censore dei palinsesti, la net neutrality si propone(va) di fare l’esatto opposto, ovvero evitare l’ingerenza dei fornitori di servizi e di altri soggetti sul traffico della rete.
La questione è dunque politica, ma gravida di conseguenze giuridiche.
Negli USA il dibattito sulla net neutrality si porta avanti ormai da decenni, stante anche una congenita difficoltà del Congresso ad intervenire. Proprio per tale ragione le principali battaglie si sono tenute sul fronte giurisdizionale e delle agenzie governative.
Se il termine è stato coniato solo nel 2003 da Tim Wu nel suo paper “Network Neutrality, Broadband Discrimination” (mentre un altro celebre giurista, Lawrence Lessing, si era già occupato dei diritti digitali statunitensi), il dibattito era già sorto con l’apertura della rete al grande pubblico: sin da principio questa fu considerata un servizio di informazione (information provider) e non un servizio di telecomunicazione di rilevanza pubblica (common carrier). Ciò ha escluso in partenza questi operatori dall’applicazione del Titolo II del Communication Act del 1934 ed in particolare della sec. 202, che pone un generale divieto di discriminazione e la materia sotto la sorveglianza della FCC.
Molte furono le voci contrarie a questa impostazione ed i tentativi di aggirare la normativa con la prassi. Già nel 2004 la compagnia telefonica Madison River Communication si accordò per pagare una sanzione al Tesoro per aver impedito l’accesso ai servizi VoIP ai suoi utenti e nel 2006 la FCC approvò l’accordo di fusione AT&T/Bell South contenente l’impegno “not to provide or to sell to Internet content, application, or service providers, […], any service that privileges, degrades or prioritizes any packet transmitted over AT&T/BellSouth’s wireline broadband Internet access service based on its source, ownership or destination.”
Ma le più grandi controversie hanno riguardato Comcast, la più grande compagnia al mondo di broadcasting. Nel 2007 si appurò che bloccava il traffico di BitTorrent (software che permette il trasferimento di file, principalmente audio e video, tramite l’omonimo protocollo) e le attività peer-to-peer, con l’asserito fine di regolare il traffico della rete, che altrimenti si sarebbe congestionata per i troppi dati trasmessi contemporaneamente. La FCC si oppose a questa pratica e ordinò a Comcast di non interferire con l’attività degli utenti, argomentando sulla base della dottrina dei poteri impliciti. Ma l’argomento non convinse la Corte d’Appello del Distretto della Columbia, che non trovò nel Communication Act una base giuridica sufficiente per regolare le condotte degli ISP.
La FCC cercò di superare il problema con l’approvazione nel 2010 dell’Open Internet Order, ma ancora una volta fu la Corte d’Appello del Distretto della Columbia a arrestare l’azione dell’Autorità (in Verizon Communications Inc. c. Federal Communications Commission), stante la mancata qualificazione degli ISP come common carrier e dunque non soggetti alle norme del Titolo II.
Sebbene non mancasse chi sosteneva la competenza della FCC già sussistente sulla base della sec. 706 del Telecommunication Act del 1996 (che prevede una generica previsione sullo sviluppo dei servizi avanzati di telecomunicazione), alla maggioranza dei commentatori e della classe dirigente sembrava necessario introdurre espressamente la rete internet nel Titolo II.
Fu per questo che la FCC nel 2015 prese una controversa decisione (ma tutte le sue decisioni in materia hanno rispettato la composizione ‘politica’ della commissione, dividendo i democratici dai repubblicani), preceduta il 14 settembre dal “rallentamento di internet”, manifestazione posta in essere da OTT del calibro di Netflix, Reddit, Twitter e Tubmlr per dar dimostrazione di cosa sarebbe stato navigare in internet – a loro avviso – laddove non si fosse tutelata la net neutrality.
Il 12 giugno 2015 con un altro Open Internet Order sono infatti entrate in vigore le regole della FCC sulla net neutrality, restate in vigore fino al 14 dicembre u.s., giorno in cui sono state soppresse.
Ma cosa prevedevano queste regole? Tre i pilastri (le cd. bright line rules) su cui si fondavano: no blocking, no throttling e no paid prioritization per cui rispettivamente era sia vietato bloccare che alterare l’accesso a determinati contenuti, applicazioni o servizi e si prevedeva il divieto di “corsie veloci” per cui gli ISP non potevano accettare pagamenti per offrire accessi più veloci a determinati contenuti o servizi.
Va precisato che la decisione della FCC si applicava nell’ambito dei servizi di accesso a banda larga (fissi e mobili) rivolti ai consumatori, restando escluse le applicazioni per le imprese, le reti private virtuali, i servizi machine to machine e i content delivery networks. Erano altresì esclusi i servizi specializzati (domotica, smart cities, smart grid, telemedicina), in quanto la no paid prioritization si applicava al livello di rete (protocollo IP) e non ai protocolli superiori del modello TCP/IP.
Ciò in quanto si riteneva che fosse critico sul piano della concorrenza il solo segmento della banda larga al consumatore, ossia la vendita al dettaglio, mentre erano già possibili – in quanto concorrenziali – accordi tra internet service provider e content provider in altri mercati limitrofi.
Dunque, il 14 dicembre con un voto politico, in cui i tre repubblicani hanno votato a favore e i due membri democratici si sono dichiarati contrari, si è tornati alla disciplina antecedente al 2015, con un sostanziale abbandono della net neutrality.
Cosa succederà nell’immediato? Innanzitutto un’espressa spogliazione della competenza della FCC: in futuro l’unico ente competente a sorvegliare sul mercato sarà la FTC, ovvero la Federal Trade Commission, accentuando dunque la vocazione mercatoria e concorrenziale della questione. L’unico principio cardine rimasto in piedi sarà quello della trasparenza, per cui dovranno essere rese note le eventuali limitazioni presenti nel contratto.
Per il resto tutto sarà lasciato agli ISP che potrebbero svolgere forme di discriminazione ora legittime: ad esempio favorendo i servizi che offrono anche in qualità di content provider (ad esempio, AT&T offre un proprio servizio streaming), chiedendo un pedaggio supplementare per accedere al resto del web, oppure potrebbero chiedere ai content provider non verticalmente integrati di pagare per rendere prioritari i loro servizi. Le caratteristiche della rete internet quale two-side market permette inoltre di pensare a innumerevoli combinazioni dei fattori, che rischiano di privilegiare l’incumbent a discapito dell’innovazione, contrariamente a quanto ha fatto la rete fino ad oggi.
I sostenitori del nuovo corso della FCC, come i 60 principali fornitori di tecnologie per gli internet service provider, ritengono che le evidenti maggiori entrate di queste saranno reinvestite per aumentare l’ampiezza di banda di cui i nuovi servizi hanno sempre maggiore bisogno, nonché per investire in zone di digital divide. A quest’ultimo proposito, tuttavia, resta doveroso chiedersi se, anche con maggiori profitti, gli operatori saranno invogliati ad investire in aree soggette a fallimento di mercato senza obblighi in tal senso.
Da notare che nel dibattito è rimasto in buona parte escluso il freedom of speech di cui al I emendamento, essendosi posto maggiore accento sula libera concorrenza e sul libero mercato anziché sulla freedom of speech. Già nel caso Reno v. ACLU si è messo in luce come decisioni governative che riguardano quest’ultima libertà devono superare la presunzione di lesività al libero scambio di idee. Resta pertanto aperto l’interrogativo se la misura in questione sia in grado di avvantaggiare o meno il marketplace of ideas che è oggi internet.
Difficile ipotizzare le conseguenze per il resto del mondo: sebbene in realtà vicine agli USA come l’Unione Europea (che ha preso formalmente posizione con il Reg. (UE) 2015/2020) e il Canada (con una legislazione che riconosce ISP quali servizi di pubblica utilità dal Telecommunications Act del 1993) la neutralità sia assodata, potrebbero esservi seri ostacoli per i fornitori di contenuti nostrani che intendano offrire servizi sul territorio statunitense.
Per il futuro viene da chiedersi se quella lanciata da Chris Anderson (direttore di Wired) nel 2010 come una provocazione “The web is dead” non sia invece una profezia che va avverandosi. Non la fine della rete, ma la fine di uno spazio su cui liberamente navigare (perché divenuto troppo lento) a favore di monadi nel deserto rappresentate da grandi piattaforme chiuse o semi-chiuse (social network, musica e video on demand, gaming, e-commerce). Non appare agevole infatti, negli Stati Uniti, immaginare un futuro roseo per piccole aziende e start-up che non potranno permettersi di offrire i propri servizi sulle corsie preferenziali della rete.
La partita è ancora aperta e, nell’imminente, c’è da ipotizzare almeno un tentativo di presa di posizione del Congresso per tramite del Congressional Review Act, che gli consenta di riesaminare e eventualmente privare di efficacia le disposizioni adottate dalle agenzie federali. Malgrado talune voci dissenzienti tra i repubblicani, la maggioranza di cui essi dispongono in entrambi i rami lascia dubbi sull’esito della procedura che dovrebbe, in ogni caso, passare al vaglio presidenziale. Parimenti molte sono state le dichiarazioni di avvio di vertenze legali, motivate sia dall’arbitrarietà della decisione (che contrasta con una decisione presa solo due anni fa, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto) sia a ragione della violazione della procedura di notice and comment (viziata, si dice, dal furto di identità di milioni di partecipanti).